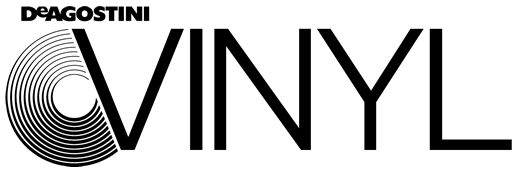Alla fine degli anni ’70 Trevor Horn ha annunciato il futuro con The Age of Plastic. Sembravano canzonette e invece era una rivoluzione.
di Andrea Pedrinelli
articolo originariamente pubblicato su Vinyl n.7 (marzo 2019)
[Continua da Trevor Horn: Video Killed The Radio Star – pt. 1 di 2]
Che eredità lasciano alla storia, firme come quella del Boss o di David Bowie?
Vedi, io penso che il pop sia soprattutto una via per comunicare i sentimenti profondi di una persona; quando ci riesce resiste nel tempo. A quell’epoca c’erano molti uomini e donne in grado, scrivendo, di comunicare ed emozionare, ora ci sono team di autori che seguono tecniche di scrittura. C’è molta più professionalità, adesso: ma inevitabilmente anche meno profondità.
Però nell’album ridai voce anche a tante icone anni ’80 sottovalutate, specie a livello critico, dagli A-Ha ai Duran Duran. Quindi c’era qualcosa anche lì, di valido?
Certo. Il problema fu che molti di quella generazione non sapevano suonare bene dal vivo. Anche perché dilagava il playback, che finì quasi con il sostituire i live perché consentiva di esibirsi persino agli incapaci e di far ascoltare alla gente i dischi nella loro veste originale, quella che gli si vuole vendere su disco. Per questo la critica, ma non solo, non ama molti artisti dell’epoca. Senza scordare che subito prima, nei ’70, quasi tutti gli artisti di successo avevano solide radici blues o R&B e c’erano tantissimi grandi musicisti in scena: pensa agli Who o agli stessi Yes. I gruppi degli ’80 sembravano band di liceali, al confronto. Del resto Neil Tennant dei Pet Shop Boys era un giornalista quando fondò il gruppo! Solo nel tempo lui e altri sono diventati musicisti veri.
Che cosa pensi lasceranno alla storia, invece, gli anni che stiamo vivendo?
Bella domanda. Non saprei neppure citarti cose che mi convincano, così a bruciapelo… Pensa che di recente ho apprezzato solo lo Springsteen dello spettacolo di Broadway! Oggi si fanno singoli, ma ci sono poche idee e dischi completi non se ne sentono più, figurarsi dunque trovare qualcuno capace di proporre un’infilata di quattro-cinque album di qualità.
Fra l’altro nel tuo nuovo disco tu torni alle radici basiche dei pezzi per dar loro nuovi colori e forme: e mi pare di capire che faresti dunque fatica, a trovare pezzi di oggi, magari rap o hip-hop, su cui agire allo stesso modo…
Non amo ascoltare quelle cose. Non le trovo musicali, non arrivano al cuore, non vi riconosci identità artistiche precise. Ho prodotto anche la dance, che è un genere limitato, ma il rap lo è molto, molto di più.
Come si trova un talento da produrre nel 2019?
Come lo si trovava nel 1979. Ci sono cinque caratteristiche necessarie per essere un talento. Uno: avere voce chiara, calda, estesa almeno un paio di ottave, capace di reggere anche sui bassi. Due: saper scrivere belle canzoni o almeno avere accesso a un autore capace di farlo, perché senza canzoni la voce non serve. Tre: possedere carisma, ovvero entrare in una stanza e far voltare tutti, mostrare una propria diversità rispetto alla massa. Quattro: avere salute in tutti i sensi, perché far musica è un mestiere duro e persino una Amy Winehouse ha pagato la sua fragilità mentale. Cinque: voler veramente arrivare, che poi è la cosa più importante. Intendiamoci, non è che uno debba avere tutte e cinque queste cose insieme, però conta che la media sia alta. Prendi Dylan: non c’era la voce, ma il carisma era brillante e la scrittura eccezionale”.
Dove porteresti oggi un talento così individuato? In Tv, nei talent, sul web, alle residue major discografiche, a un’etichetta indipendente, prima dal vivo?
Non c’è una ricetta. Ma conta avere un disco, con dentro qualcosa di buono. La mia esperienza mi dice che se proponi canzoni valide, la gente se ne accorge. Ti faccio un esempio, Declan McKenna. Nel Regno Unito è arrivato dal nulla alle hit parade grazie “soltanto” all’autoproduzione su YouTube di una canzone forte come Brazil. Certo, se hai tutti i requisiti di cui sopra, prima o poi arrivi senz’altro. A me capitò con Seal, appena si muoveva la gente restava ammaliata. Però dietro l’immagine c’era un artista.
Si può dire che è proprio Seal il tuo miglior biglietto da visita come produttore?
Lui e il suo secondo disco, senz’altro. Ma anche i Frankie Goes To Hollywood. In generale sono contento di non aver mai dovuto cimentarmi con produzioni sottotono o lavorare con artisti che musicalmente non stimavo.
Secondo Trevor Horn è ancora possibile fare canzoni davvero nuove, nel 2019?
Penso di sì, ma attenzione: il punto sono i testi. Un’ottava è di dodici semitoni da secoli, e anche una composizione che piace può sempre nascere; ma è dura giungere a testi che raccontino l’esperienza reale della gente e siano figli di una personalità tanto originale da farsi riconoscere e da poter restare nel tempo.
Che cosa ha ucciso il far musica di una volta, per parafrasare la famosa canzone dei Buggles?
Oh, quel brano vale ancora: anche la musica l’ha uccisa la televisione, il video. Eppure non serve null’altro, per arrivare, se hai in mano una bella canzone. Basta la chitarra, basta la voce. Like a Rolling Stone di Dylan conquistò il mondo senza bisogno di clip, e quando ne produssi una cover con Jeff Beck e Seal per Amnesty nel 2012 la magia pezzo+chitarra+voce vendette ancora tantissimo.
Come festeggerai, artisticamente parlando, i tuoi 70 anni?
Con il tour di questo nuovo lavoro portando un’orchestra sul palco assieme a me. Anche se mi fa un effetto strano, pensare di aver iniziato quarant’anni fa…
Sei ottimista, Trevor, sul futuro della musica “leggera”?
Io sono sempre ottimista perché amo questo mestiere e credo che la gente cercherà sempre la musica. E anche se oggi non sappiamo “chi” o “come” ce ne potrà donare ancora di bello, credimi: il pop non morirà mai.