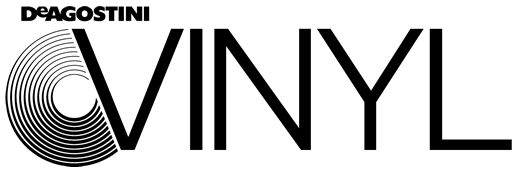È alto un metro e sessantacinque, mai avuto il “fisico del ruolo”. Non proprio simpatico, anzi, volentieri scorbutico (ricordate la sceneggiata del Nobel?). E bizzoso, testardo, elusivo. Eppure (o forse proprio per questo) dal profondo del secolo scorso Bob Dylan attira l’interesse e centrifuga i sentimenti di milio-ni di persone con le sue avventure di musica e di vita, le prese di posizione, i segreti e i silenzi. Più che un semplice uomo è un’enciclopedia, più che un arti-sta un’arte, di più, una scienza: la Dylanologia, disciplina all’incrocio tra letteratura, musica, filosofia, sociologia, che in tutto il mondo appassiona migliaia di ammiratori elevati al rango di maniacali studiosi. “Appassionare” è poco. La parola giusta è probabilmente quella che ha pronunciato tempo fa Christo-pher Ricks, studioso di letteratura inglese e dylanologo emerito. «Io non insegno Dylan», ha confessato candidamente. «È soltanto un’ossessione».

DAL MIDWEST ALLA BIG APPLE
Questa ossessione viene da lontano, dagli anni ’60, che sono il cuore della nostra storia. Dylan è un provinciale dei Grandi Laghi che arriva a New York ven-tenne, nell’inverno più freddo del secolo. È un ossimoro vivente: timido ma spavaldo, ingenuo eppure lucidissimo, ferocemente determinato, arcisicuro che se ci sarà uno che riuscirà a farcela, quello sarà lui. È una spugna, assorbe tutto: storie, leggende, trucchi di scena, vecchie ballate e blues da dischi che gli amici gli prestano e che lui non restituisce. Si ispira a Woody Guthrie, l’eroe ottimo massimo, che giace esausto in un letto di ospedale per un male incurabi-le e non può più fare musica. Lo va a trovare, diventa amico della famiglia e dei suoi amici, ed è come se fosse un’investitura: il nuovo Guthrie, il cantore dei più miseri e degli oppressi, il paladino dei diritti civili, da quel momento sarà lui. Canta con voce nasale, suona con puntiglio armonica e chitarra, adatta con maestria vecchie folk song all’aria nuova degli anni ’60. Il folk è in auge in quei giorni, specie tra gli studenti e gli intellettuali di città, e Bobby trova presto la via; una dura gavetta nei localini del Greenwich Village porta all’apprendistato dell’album d’esordio e poi al primo successo, con dure canzoni contro i pa-droni della guerra, gli sfruttatori e l’Apocalisse prossima ventura che si alternano a ballate romantiche di estasiante bellezza. Prima che lui vada in classifica ci arriva una sua canzone, Blowin’ In The Wind, portata al successo nel 1963 da Peter, Paul & Mary; diventerà un tormentone nei giorni più infocati della protesta giovanile e del movimento per i diritti civili, e sarà il primo avviso per il ragazzo di quanto può essere forte il luogo comune.
I TEMPI CAMBIANO
L’idillio con la comunità folk dura fino al 1964, consolidato dal legame, anche affettivo, con una star di quel mondo, Joan Baez. Vanno in tour insieme nei college dove cova la protesta della contro America, li chiamano “il Re e la Regina del folk”. Ma Dylan è insofferente. «Il mondo della musica folk era come un paradiso che dovevo lasciare», scriverà anni dopo nell’autobiografia, «così come Adamo aveva dovuto lasciare il Giardino. Era troppo perfetto». Sembra una follia, invece è la mossa decisiva. Con Another Side of Bob Dylan (1964) Bob sostituisce Guthrie con Rimbaud e Ginsberg, contorcendo i testi in lunghe catene di parole visionarie; con Bringing It All Back Home e Highway 61 Revisited, l’anno seguente, piega anche la musica alle nuove esigenze, forgiando un rock blues duro e scorticante, che rinnega la purezza acustica dei primi dischi e abbraccia la sporca bellezza dei nuovi suoni elettrici. È un cambio traumati-co per gli appassionati e uno strappo con la comunità folk, che si consuma sera dopo sera negli show in giro per il mondo dopo che al festival di Newport, estate 1965, Dylan ha reso pubblica la sua eresia ed è stato fischiato e cacciato dal palco.
IL PROFETA NELL’OMBRA
Non gli fanno cambiare idea, nessuno ci riuscirà mai. Continua a inseguire un suono speciale, «wild thin mercury sound» lo definirà, e sbalordisce per la quantità di idee e canzoni nuove che riversa, influenzando tutti, anche gli immensi Beatles, anche i californiani e gli Hendrix che di lì a poco prenderanno il potere. Pubblica un album addirittura doppio, Blonde On Blonde, scrive un libro, progetta un film, mentre un avido manager lo costringe alla routine di cen-to e più serate all’anno. È troppo, è un peso insopportabile, e il fato gli viene in soccorso. Un incidente in moto nei dintorni di Woodstock, dove ha preso casa fuggendo dal Village, lo mette fuori gioco nell’estate del 1966, fornendogli uno straordinario pretesto per far perdere le proprie tracce. Il più fantasioso dei registi non avrebbe potuto scrivere una sceneggiatura migliore: il profeta che si leva di mezzo nel momento preci-so in cui le sue profezie si avverano, 1966-67, quando la scena rock cambia pelle e linguaggi, diventa adulta, si apre ai Grandi Quesiti e ai Grandi Numeri proprio come quel ragazzo emaciato e fragile aveva insegnato. Anche il sequel è imprevedibile. Quando Dylan torna, con John Wesley Harding prima e Nashville Skyline dopo, le sue canzoni stupiscono e stordiscono, lontane come sono dal carnevale di suoni che impazza, portate non più a rinnegare la tradizione ma a onorarla in una maniera che per qualcuno ha l’aria del “tradimento”.
È GIÀ TUTTO FINITO?
A trent’anni Dylan è un appagato padre di famiglia che si è levato di dosso un manager ingombrante e decide da sé, spesso e volentieri contro tutto e contro tutti. Incide anche quando non è molto ispirato, licenzia un’antologia di inediti inascoltabili e nel 1974 decide di ritornare sulle scene facendosi accompagnare dagli amici degli anni d’oro, The Band. Il live che ne viene non è così memorabile, ma intorno crescono due Lp uno più bello dell’altro, Planet Waves e Blood On The Tracks. Quest’ultimo, versione matura e raffinata del “wild thin mercury sound”, mostra un caratteristico tic dylaniano: il giudizio sbagliato sulle proprie opere. La prima versione dell’album è semplicemente perfetta, ma il testardo Bobby non è convinto e modifica la scaletta senza aggiungere valore, anzi, levando qualcosa. Quante volte aveva fatto lo stesso con le canzoni degli inizi, scartandone di meravigliose; altrettanto farà anche dopo, e ba-sti l’esempio di Blind Willie McTell, capolavoro acclamato dai fan che l’autore recupererà solo per una antologia di inediti.
Il tour del 1974 rinfranca Dylan, che con una spettacolare piroetta delle sue ribalta la posizione nei confronti della musica live. Dopo otto anni di quaresima, gli è tornata voglia di salire in scena e di offrire al pubblico le sue canzoni del presente e del passato; mai trop-po uguali alla matrice originale però, anzi, volentieri smontate, sfigurate, con un gusto tra lo sperimentale e il perfido. Organizza un circo itinerante con amici chiamato Rolling Thunder Revue, suonando in piccoli centri senza preavviso, gira da regista un film che i critici prenderanno a ceffoni e presto sparirà (Renaldo & Clara) e con santa pazienza accetta la parte di “dinosauro” in una scena che vuole essere giovane a tutti i costi. Il vecchio istinto di andare controcorrente, però, torna a visitarlo.
LA FASE MISTICA
Mentre il rock si invaghisce di punk e new wave, Bobby si interroga sul suo credo religioso e legge la Bibbia, che sempre lo ha ispirato, da un altro punto di vista. Accantona l’ebraismo e diventa cristiano rinato, modellando sulla nuova fede alcuni dei testi più devoti e controversi di tutta la sua opera. I tre dischi del periodo, 1978-1981, ricevono un’accoglienza fredda e ostile, ma con il tempo verranno in buona parte rivalutati. Smussato qualche testo d’amor divino troppo acceso, il gospel è sempre stato una radice importante della musica dylaniana e non suona fuori luogo. La trilogia religiosa introduce il decennio più difficile, gli ’80, un alternarsi di ottimi dischi (Infidels; Oh Mercy) e balbettamenti (Empire Burlesque; Knocked Out Loaded) in cui per la prima volta Bob Dy-lan dà l’impressione di non condurre lui il gioco ma di farsi trascinare dai tempi. La confusione si riflette anche in scena. Nel mezzo del cammin della sua vita, Bobby è convinto di avere perso l’appeal e si rifugia dietro il paravento di altri. Suona con i Grateful Dead, va in tour con Tom Petty & The Heartbrea-kers e, come racconterà nell’autobiografia, medita di ritirarsi. Una sera del 1987, a Locarno, la scena madre. Dopo essere arrivato alle soglie di una crisi di panico, Dylan ritrova come per miracolo voglia, passione, forza, e un’energia dimenticata torna a sostenerlo. «Possedevo una facoltà nuova, che sembrava superare tutti gli altri umani requisiti. Se mai avessi voluto una nuova motivazione, ora l’avevo. Era come se fossi diventato un artista nuovo, uno scono-sciuto nel vero senso della parola». Lo sconosciuto non ha alcuna voglia di ritirarsi dalle scene, anzi, «invece di essermi perso chissà dove alla fine di una storia, capii che in realtà ero all’inizio di una nuova». Poche settimane più tardi inizia il giro di concerti che dura ancora oggi, il leggendario “Never Ending Tour”, vicinissimo al traguardo delle 3.000 date che saranno probabilmente raggiunte entro il 24 maggio 2019, settantottesimo compleanno dell’artista.
SEMPRE SORPRENDENTE
L’impegno regolare in scena è il perno della vita artistica del Dylan maturo e poi senile, il segno di un “mestiere” condotto con professionalità e puntiglio, senza enfasi. Che cosa deve fare in fondo un musicista se non suonare davanti a un pubblico? Certo poi ci sono anche i dischi, le canzoni nuove e la siste-mazione dell’immenso archivio raccolto a partire dal 1991 nella collana Bootleg Series; e il volume 1 di una affascinante autobiografia su cui pochi avrebbero scommesso (Chronicles), e la copiosa produzione da pittore più volenteroso che di talento, e un docu-film curato da Martin Scorsese in cui Bobby si rac-conta con sincerità, guarda perfino verso la telecamera e qualche volta addirittura sorride (No Direction Home). Lo scorbutico resta un tipaccio, come di-mostrerà il teatrino un po’ antipatico del Nobel, ma qualche volta si mostra sorprendentemente socievole. Come quando nel maggio 2006 inaugura una trasmissione radio per l’emittente XM Satellite, Theme Time Radio Hour, presentando canzoni legate a specifici temi scelti di volta in volta (il tempo, le mamme, il bere, il baseball, il caffè, la galera) e rivelando una notevole sapienza nel campo della musica americana fino agli anni ’50.
UNA LEGGENDA VIVENTE
Questa sapienza non può stupire, riandando alle origini dell’artista, ma in qualche modo fa impressione. Negli anni ’60 Dylan era il paladino della contempora-neità, il nuovo più nuovo di un mondo proiettato verso il futuro. Da grande, da vecchio, torna sulle piste del passato come un antropologo musicale alla Alan Lomax, e nei suoi dischi intesse volentieri fili di canzoni anni ’30 e ’40, quasi una ricerca del suo tempo perduto. Non tutti i fan sono disposti ad accettare il gioco e gli album che vengono dopo Time Out of Mind (1997), un capolavoro indiscusso, sono oggetto di polemiche anche accese. Bobby, però, tira dritto per la sua strada, si concede anche il vezzo di un album di canzoni natalizie e respinge con indifferenza le polemiche suscitate da chi ha scoperto che pezzi interi di alcuni suoi testi recenti (canzoni, ma anche l’autobiografia) sono prelevati pari pari da altre fonti. In fondo è un procedimento folk, da Omero in avanti si fa così e l’originalità assoluta è un mito del Romanticismo. Qualche dylanologo si spinge oltre e avanza l’ipotesi che nel libro e nelle sue canzoni Dylan abbia seminato migliaia di enigmi, giochi di parole, allusioni, doppisensi, una specie di personale “codice Da Vinci”. Per tagliar corto, Bobby a partire dal 2012 chiude il rubinetto delle canzoni originali e si dedica al repertorio di decenni passati, cominciando con Frank Sinatra (Shadows in the Night e Fallen Angels) ed estendendo poi la ricerca a brani di altri interpreti, tratti sempre da quello che in gergo si chiama “Great American Songbook”. La serie è arrivata finora a cinque Cd, e per gli appas-sionati basta e avanza; ma Bobby è un testardo e dispettoso, si sa, e nessuno esclude che potrebbe continuare. Fermo restando che non si tratta di cover, termi-ne che proprio non gli piace. «Erano pezzi sepolti, chiamiamoli così. Tutto quello che ho fatto è stato estrarli dalla tomba e riportarli alla luce». Anche se un al-bum di canzoni originali manca da Tempest, dove spiccano un emozionante ricordo di John Lennon e un lungo brano ispirato alla tragedia del Titanic, Dylan continua a farci compagnia con nuovi spunti. Ogni anno dagli archivi escono nastri preziosi, come l’anno scorso quando venne ricostruita in nove Cd e Dvd la stagione delle “canzoni cristiane”, o come quest’anno, con la pubblicazione integrale dei materiali di Blood on the Tracks, uno degli album più amati dai fan. Bobby sembra aver fatto sua la lezione di Jerry Lewis («Non faticare ogni giorno per costruirti un futuro, ma lavora duramente per costruirti un decente passato, perché ti ricorderanno solo per quello») e non mostra di avere questa gran voglia di canzoni nuove. Ha fatto già così tanto, e alcuni angoli della sua Amazzonia sono ancora inesplorati. La fondazione di un miliardario dell’Oklahoma ha comperato qualche tempo fa il suo ponderoso archivio per una cifra intorno ai venti milioni di dollari e si sta preparando a esporlo in una apposita sezione del Gilcrease Museum di Tulsa. Onorato con il Nobel, introdotto da subito nella Rock & Roll Hall Of Fame, insignito delle più alte onorificenze in patria e in Europa, Bobby è pronto al passo ulteriore e decisivo: diventare un museo.
Quest’articolo è tratto dal numero di De Agostini Vinyl in edicola, firmato da Riccardo Bertoncelli.