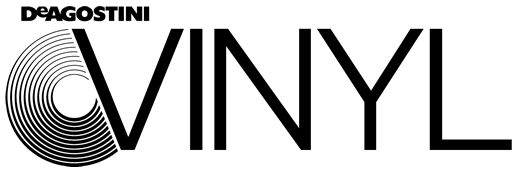Una chiacchierata con Franz Di Cioccio e Patrick Djivas, anime storiche della PFM, per scoprire il senso dell’imperfezione come misura della bellezza
[di Valentina Giampieri – intervista integrale pubblicata su Vinyl n.9]
«Lucio chiama i musicisti mentre suona. Fa cenni con la testa. Lancia tutti gli interventi che ci sono nel brano. Ascoltando attentamente il disco, si sente addirittura la sua voce che chiama “Baldan, Baldan, Baldan…!” e subito Dario Baldan Bembo entra con l’organo. Quando è il momento di calare, abbassa un po’ la testa, poi la tira su di nuovo e si riparte in quarta. Si va avanti così, suonando tutti insieme, fino al momento in cui arriva l’ultima indicazione: “Batto quattro e finiamo, eh”. È fatta! Il pezzo c’è!».
Dio mio no di Battisti è nata così: con una jam session di 7 minuti e 31 secondi, improvvisata e incisa tutta d’un fiato. Buona la prima.
Quello che sentiamo è quello che è accaduto in quei 7 minuti e mezzo. Niente sovraincisioni o correzioni.
Se chiedessero una prestazione del genere a un giovane musicista contemporaneo, anche uno dei più bravi, ne sarebbe atterrito. Lui, abituato a Pro Tools e ad avere tutto il tempo che occorre per limare, campionare, aggiustare, sistemare e rendere il risultato finale digitalmente impeccabile. O quanto meno a provare il pezzo prima di lanciarsi per la take definitiva.
Ma qui nessuno, tra quelli che suonavano, sapeva bene cosa sarebbe successo da un momento all’altro. L’idea di Battisti era proprio cercare la scintilla spontanea, la magia irripetibile, l ’antitesi di quello che oggi succede in uno studio di registrazione. Ce lo ha raccontato Franz Di Cioccio, che lo sa bene perché quel giorno, negli Studi Ricordi in via dei Cinquecento a Milano, alla batteria c’era lui.
La PFM è un incrocio incredibile. Musicisti da studio, musicisti da palco, musicisti sperimentali e prog.
Sembra impossibile riuscire a eccellere in tutti e tre i campi. Eppure lo hanno fatto, e non solo per se stessi: per Lucio Battisti nel primo caso, per Fabrizio De André nel secondo, per gli ascoltatori italiani e stranieri nel terzo.
E in Italia nessuno come loro ha vissuto il passaggio dall’era antica dello studio di registrazione a quella moderna.
Basta parlare con Franz Di Cioccio e Patrick Djivas per rendersene conto.
La perfezione ieri e oggi
Franz Di Cioccio
«Oggi si è lontanissimi da questo tipo di idea, i musicisti hanno tutta la tecnologia necessaria per viaggiare sul sicuro, qualsiasi cosa facciano. Oggi il più bravo è quello che riesce ad andare perfettamente in sincrono con il clic in cuffia. Adesso si rincorre la perfezione fine a se stessa, ma all’arte quella perfezione non è mai servita. Per esempio, Lucio aveva fatto la gavetta vera, quella che si faceva una volta. Andando a bottega, che per lui era la sala da ballo, tutti i santi giorni, dalle nove alle due di notte. Soltanto così capisci davvero che cos’è la musica. Doveva suonare qualsiasi cosa e così, quando ha cominciato a scrivere per conto suo, aveva le idee molto chiare su quello che voleva tirar fuori da una canzone. Ascoltando bene Il tempo di morire, lo si sente battere sul parquet e, a un certo punto, chiamare “finale!”. E lui lasciava tutto, perché anche le sbavature facevano la differenza».
Patrick Djivas
«La perfezione senza la creatività non ha alcun senso. Una volta, a Los Angeles, ho assistito alle prove di Frank Zappa e sono rimasto sconvolto. Andavano avanti anche due ore di orologio per fare quattro battute. I musicisti non ce la facevano più, ma finché il risultato non era come voleva lui, non si poteva proseguire. Zappa però era uno dei musicisti più creativi di tutti i tempi. Non era schiavo della tecnologia, ma sapeva esattamente quello che voleva ottenere. E comunque non aggiustava gli errori con il mixer o il computer. La versione finale era perfetta, ma conteneva quello che era stato realmente suonato. La perfezione di oggi è sterile. In confronto alla sua, fa ridere».
Creatività Vs Tecnologia
Patrick Djivas
«I Beatles hanno fatto una sperimentazione pazzesca, hanno fatto tutto e il contrario di tutto. Si dice che John Lennon, per ricreare l’effetto Leslie (il sistema di altoparlanti rotanti che conferivano al suono una particolare modulazione, n.d.r.), avesse addirittura proposto di farsi appendere per i piedi, in modo da ondeggiare e cantare con il megafono, sospeso in aria, sopra i microfoni. All’epoca, poi, si lavorava su due piste e la prima sincronizzazione è stata fatta perché John Lennon non riusciva a doppiarsi. George Martin usava questa tecnica, facendo cantare lo stesso cantante due volte, per rafforzare la voce. McCartney, che era precisissimo, si doppiava talmente bene che a volte andava così in controfase da annullare l’effetto. John Lennon invece scordava le parole e cambiava sempre qualche nota. Così Martin, per risolvere il problema, chiese a un tecnico – di quelli che all’epoca avevano il camice bianco – di splittare la traccia voce su due registratori sincronizzati tramite un motore esterno. Si dice abbiano usato quello di una lavatrice. E con la mano, ogni tanto, toccavano la flangia di una delle due bobine per rallentarne la velocità. L’effetto, che oggi è uno dei più utilizzati nella musica, si chiama flanger e arriva proprio da lì».
Franz Di Cioccio
«In Heroes di David Bowie si sente la chitarra di Robert Fripp che tiene una nota lunghissima, una cosa praticamente impossibile. Non si sa come abbia ottenuto quell’effetto. Tutti pensano abbia usato un ebow (un piccolo strumento con un circuito elettronico che avvicinato alle corde consente di ottenere un sustain illimitato, n.d.r.), ma in realtà quel sound così particolare pare sia il frutto, in parte casuale, di una sovrapposizione di tracce. Senza dubbio anche per Bowie gli “incidenti” erano più importanti delle rifiniture ossessive. Quando non avevamo i computer, anche noi ci siamo inventati qualche trucchetto. Per L’isola di niente, per esempio. Non riuscivamo ad attaccare la parte del coro a quella della band che suonava. Così abbiamo messo il nastro al contrario e fatto un break che cominciava dalla coda del colpo. Così restava la coda e su quella partiva l’altro pezzo».
Patrick Djivas
«Negli anni ’50 il basso elettrico non era nemmeno contemplato, si usava il contrabbasso. La ritmica veniva registrata su due piste, si trasferiva tutto su una delle due e sull’altra si incidevano i cori. Poi si ripeteva la procedura in una sorta di ping pong. All’epoca c’era un bassista fenomenale, James Jamerson, quello che ha creato il sound della Motown. Capitò che in studio, dopo tutti quei passaggi, la sua linea di basso sparì dal brano per un errore del tecnico. Rifarla con il contrabbasso su una pista indipendente non avrebbe funzionato, per via del suono troppo grosso. Risolsero il problema, grazie a un basso Fender, che ha un suono decisamente più contenuto. Glielo prestò un ragazzo per l’occasione. Da lì in poi il basso elettrico divenne un elemento indispensabile in studio».
[Continua con la seconda parte]