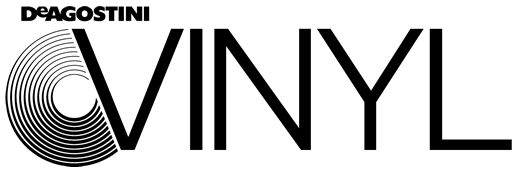Intimità, azioni semplici, memoria e prospettiva alla ricerca di un nuovo equilibrio di suoni e parole che confermano l’identità del cantautore romano, che prosegue il suo percorso di narratore delle emozioni umane. Tra tradizione (il suono analogico) e tradimento (l’elettronica).
[di Silvia Gianatti – articolo pubblicato su Vinyl n. 11 / continua da Niccolò Fabi e la ricerca di identità – l’intervista pt. 1/2]
In che cosa pensi sia la tua forza più grande?
Non suono, non scrivo e non canto in maniera speciale. Ho molti amici che lo fanno meglio. Ma mi rendo conto che quando accedo a un certo tipo di intensità, quello che scrivo non è una canzone. È più importante. Diventa qualcosa di diverso. Però, se non sono emozionatissimo o disperatissimo quando scrivo o canto, non funziona. La mia forza è il racconto.
Del presente?
Le canzoni e l’arte in generale devono svincolarsi dalla cronaca e inquadrare qualcosa di più grande. L’attualità è il saper raccontare il mio tempo, dar voce alla mia età e generazione, anche se il pubblico può avere età diverse. L’età conta in maniera determinante. Le mie cellule influenzano i miei pensieri, mi comunicano cose diverse rispetto al passato. Abbiamo il dovere di raccontare le stagioni della nostra vita.
Quanta attenzione metti nelle parole?
Tantissima, penso a ogni singolo vocabolo. Eppure non do più importanza alle parole, rispetto alla musica. Rivendico sempre, in maniera infantile, che io scrivo canzoni. Suoni e parole hanno per me la stessa importanza. I miei brani non sono mai facilmente “coverizzabili”, non perché siano difficili tecnicamente ma perché sono legati alla mia voce, al mio stato d’animo. Che non è comune. La mia attenzione è totale, su ogni aspetto. Ogni parola vive con un suono e una metrica. Cambiando il suono cambierebbe il significato.
La produzione è lunga?
Dipende. Rimango sempre stupito da quelle canzoni, da quei gesti artistici, che ogni artista riconosce essere fuori dal comune, che si consumano in un attimo. Scotta, per esempio, l’ho scritta in meno di un’ora. Ci sono momenti magici e quando accadono si rimane esterrefatti nel vedere qualcosa che ha una forma già costruita altrove ed esce attraverso te, già finita. Mi sono messo a suonare il pianoforte, ho trovato l’arpeggio su parole che mi ero appuntato. La canzone rappresenta quella che vorrebbe essere la mia sfida musicale in due linguaggi apparentemente inconciliabili: la lingua italiana, nel suo aspetto anche più letterario forte e lucido, dichiarativo, e la musicalità che porta al sogno. Che non mette a fuoco ma sfuoca. La sfida di Quasimodo che incontra i Sigur Rós con ripetizioni a volume sempre più basso, con lo stesso segnale che scompare all’orizzonte. La musica, il delay, gli arpeggi che stimolano questa possibilità, alternando la confusione.
La tua cifra stilistica rimane il sussurro.
Le parole non gridate sono la mia forma di dissenso che canto “pacifico e determinato”. La comunicazione attuale tende al grido, per farsi notare. Le mie canzoni portano pensieri sussurrati, che sono meno invadenti. Che possono essere considerati deboli, eppure, se non hai bisogno di urlare, vuol dire che non c’è distanza con chi ti ascolta, puoi comunicare in maniera molto più evidente.
Cosa diventa questo sussurro nei tuoi live?
Sto pensando tantissimo a questo nuovo tour. L’idea è che sia una performance artistica, non farò mai un concerto da urlare. Il pubblico è molto partecipe, emotivamente, ma questa volta vorrei farlo entrare in uno spettacolo in cui al centro ci sia l’attenzione. Regalare un viaggio. Non dovranno intervenire per forza. Certo, se cantano, non è che mi dispiace.