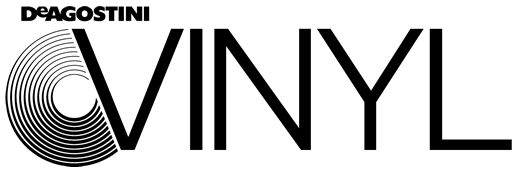Alla fine di maggio del 1968, Jimi Hendrix arriva in Italia per una serie di concerti. Renzo Chiesa, Ruggero Stefani e Luciano Regoli salgono con noi sulla macchina del tempo e ci riportano a quello storico evento
di Guido Bellachioma
intervista integrale pubblicata su Vinyl n.8 (maggio 2019)
[foto: Chuck Boyd © Authentic Hendrix]
Il 23 maggio, Hendrix arriva a Milano per il suo primo concerto italiano. Il luogo prescelto è il Piper, vicino al parco Sempione, e Renzo Chiesa è lì. Classe 1951, cremonese di nascita e milanese di adozione, grande appassionato di musica e fotografia, Renzo ha realizzato le foto di copertina e degli interni di album importanti. Delle sue collaborazioni ricordiamo: Stormy Six, Le Orme, Enzo Jannacci, Paolo Conte, Lucio Dalla, Veronique Chalot, Gaetano Liguori, Steve Lacy, Pooh. Ma in quel fine maggio di un anno rivoluzionario Chiesa è solo uno dei tanti giovani che attendono con curiosità l’arrivo sulla Terra di questo marziano del rock.
Il racconto di Renzo Chiesa
«Hendrix campeggiava con il suo faccione colorato su tutti i muri della città, non una foto ma un disegno, colorato di rosso e nero, firmato Polydor. Una bella faccia quella di Jimi, anche se i giornali lo descrivevano come un diavolo. Confesso che fui attirato più da quel manifesto che da una vera conoscenza musicale. Pochi erano i soldi per i dischi.
La tv e la radio erano ferme a Gianni Morandi, Rita Pavone e nel migliore dei casi a Elvis Presley. Di sera ascoltavo Radio Lussemburgo, che trasmetteva rock, blues, folk, la musica che cominciavo ad amare. Da lì anche Hendrix era passato.
Ero già fotografo, o meglio, Blow up, il film di Michelangelo Antonioni, aveva fatto i suoi danni su di me. Della professione sapevo poco però amavo “l’immagine”; mi incantava l’alchimia di una foto che, con la sua forza, ti proietta in un’altra dimensione, in un’altra realtà. Aspettavo con ansia la data del concerto, anche se sapevo che la mia attrezzatura fotografica era costituita da una semplice macchinetta amatoriale, neanche reflex, ma che aveva l’obiettivo tedesco, allora già una buona garanzia.
Il Piper era un locale piccolo, con giardinetto sul parco Sempione, nel palazzo della Triennale, accanto al Teatro dell’Arte, capacità circa 800 persone. Già dalle primissime ore del pomeriggio il piazzale era pieno di giovani, ben vestiti e ben pettinati, pochi capelli lunghi o eccessi estrosi. Una pattuglia di poliziotti in borghese stazionava nelle vicinanze. Tutto pronto per il concerto delle 16. All’apertura delle porte, una folla, di corsa, si accaparrò i posti migliori davanti al palco.
Mi ero attardato a fare qualche fotografia all’esterno perciò non riuscii a essere fra i primi e questo non mi avrebbe permesso di fare delle belle foto, i teleobiettivi erano oggetti inavvicinabili per le mie tasche. Mi sarei accontentato di sentirlo, forse anche vederlo, data la muraglia umana che avevo davanti.
Intanto l’attesa si faceva snervante, fischi e urla da parte del pubblico, ma di Jimi neanche l’ombra. Finalmente arriva sul palco Leo Wachter, l’organizzatore del concerto, con Hendrix. Nella calca di gente che spingeva per avvicinarsi al palco e io che cercavo di salvare la mia macchina fotografica, arriva la doccia fredda: Jimi non avrebbe suonato perché gli strumenti erano fermi in dogana per perquisizione accurata in cerca di droga.
Panico, arrabbiatura, urla e fischi, soprattutto quando ci invitarono a uscire. Jimi avrebbe suonato alla sera. Non volevamo andare via perché il biglietto serale costava di più e non volevamo pagare nessuna differenza. Alla fine vincemmo noi, niente soldi in più e pronti a rientrare in pole position.
Molti, disperati, non potevano aspettare il concerto serale, non avendo il permesso dei genitori di stare fuori fino a tardi. Io presi la mia decisione: sarei stato attaccato alla porta d’ingresso perché volevo essere fra i primi. Così dopo un’attesa snervante, ragazze in minigonna che dal palco regalavano sigarette, caldo africano e spintoni per mantenere la posizione, ecco arrivare Jimi Hendrix, vestito di scuro, due mèches bionde alle tempie e Fender Stratocaster bianca.
Per me era tutto: l’avevo a tre metri, lo vedevo bene, lo potevo fotografare e ascoltare. Insomma, il Piper non era certo adatto per l’amplificazione di Jimi e i problemi erano tanti, ma non importava. C’era lui, il pubblico era attento, ascoltava l’esecuzione del brano e, alla fine, esplodevano le urla. Jimi strapazzava le corde con i denti, suonava la chitarra dietro le spalle, strusciava lo strumento contro gli amplificatori, tutto per ottenere sonorità nuove e rivoluzionarie.
Purtroppo dopo le foto scattate all’esterno al pomeriggio e con la poca luce sul palco (inesistente su Noel Redding) ho potuto dedicare solo pochi scatti a Jimi. Oggi con le memorie digitali da tanti giga non si può capire quanto fosse difficile e affascinante utilizzare rullini fotografici da 36 immagini, che in concerto erano difficili da cambiare».
Dopo Milano, il marziano sbarca a Roma. Ruggero Stefani negli anni ’60 è un batterista di bella presenza e altrettante speranze. Inizia a suonare con Le Pupille, band totalmente al femminile, ma nel 1968 è un membro dei Fholks, che aprono per i Pink Floyd al Piper Club (18-19 aprile) e per Jimi Hendrix al teatro Brancaccio (25 maggio). Nel corso degli anni ’70 sarà anche con L’Uovo di Colombo, Samadhi, Nuova Equipe 84 e Alunni del Sole. Per il momento sta per vivere un’esperienza straordinaria.
Il racconto di Ruggero Stefani
«Le cose che ti succedono a diciotto anni pensi che possano ripetersi sempre. L’incoscienza dell’età ti convince che un avvenimento importante porterà inevitabilmente altri momenti memorabili, quindi tendi a sottovalutare il presente. Ma l’incontro con Jimi sarebbe stato irripetibile e io non me ne sono reso conto! Me lo sarei dovuto far scivolare sull’anima lentamente, spizzandolo come il quarto asso a poker, godendone ogni singolo attimo.
Il mio gruppo si chiamava Fholks, inizialmente Folks, formato da me alla batteria, Henryk (Enrique) Topel Cabanes alla voce solista, Pierfranco Pavone al basso e Claudio Baldassarri alla chitarra. Avevamo una dose abbondante di groove: quando ci esibivamo la gente saltava sulle sedie.
In quel periodo a Roma due locali andavano per la maggiore: il Piper (via Tagliamento) e il Titan (via della Meloria). I direttori artistici per una paga ridicola ci scritturavano una o due settimane: a noi interessava solo suonare.
Massimo Bernardi e Oscar Porri, direttore artistico e proprietario del Titan, avevano organizzato la tournée italiana di Jimi Hendrix. Dopo il concerto del 24 al Brancaccio, portarono Jimi, Redding e Mitchell al Titan.
Entrarono che noi stavamo suonando per la seconda volta. Erano naturalmente destinati a occupare il “vippaio”, come veniva chiamato il gruppo di poltroncine a lato della pista da ballo. Raddoppiammo l’energia e le emozioni scorrevano ancora più abbondanti in noi.
Durante i tre pezzi suonati avevamo visto Jimi sempre meno rivolto agli ospiti e sempre più interessato a noi. Applaudiva con sincerità, non solo al termine di ogni canzone. Scendemmo dal palco ed entrammo in camerino, ubriachi senza aver bevuto o fumato!».
[Vai alla seconda parte]