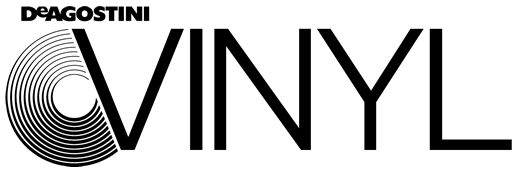quest’articolo è tratto da DeAgostini Vinyl n.3
Un americano a Milano, si può dire così. Sono nato in via San Vittore, ma ero americano fino in fondo. Cresciuto e allevato a Milano da una mamma americana, mi sentivo talmente americano che nella mia cameretta ho sempre avuto una grande bandiera a stelle e strisce, a tutta parete. Il fatto che sarei stato americano da grande non era neanche in discussione. Era scontato. Non era previsto che io non fossi americano. Ho fatto anche sei mesi in America quando avevo un anno e un anno quando ne avevo sei, facendo la prima elementare, e ci andavo ogni anno dispari praticamente, oltre che tutte le estati a casa della nonna. Il problema è che non avevo mai avuto un vero contatto con gli americani: andavo da cugini e parenti, ma restavo all’interno della cerchia familiare. Nel 1971 finalmente, a 19 anni, sono andato davvero in America, all’università. E lì mi sono accorto che c’era un problema, e cioè che fondamentalmente gli americani non li sopportavo… Ho capito di avere un interno rifiuto, che è anche un rifiuto di me stesso, di tutta quella arroganza americana, che peraltro io stesso sfoggiavo da giovane e che era in realtà una maschera che serviva a nascondere la mia profonda timidezza.
Mi sentivo davvero diverso. E non a caso i miei amici qui in Italia erano Camerini, che era mezzo brasiliano, Demetrio Stratos, greco nato ad Alessandria d’Egitto, e così via. Eravamo una specie di comunità di “spostati”, che ci rendeva anche difficile sentirci come borghesi italiani qualunque. Erano gli anni ’50 e ’60, qui c’era una omologazione fortissima. Le donne dovevano vestire con il tacco medio, le calze velate, il maglioncino di cashmere. Fuori dalle scuole di Milano, in centro, vedevi quelle mamme tutte uguali, mentre la mia non riusciva a essere come loro. Era una donna albina, americana, che faceva la cantante lirica, un soprano, e che qui molti prendevano per tedesca. Già allora le dicevano “turna al to’ Paes, tedesca!”. Per questo oggi mi riconosco in Cara Italia di Ghali. Solo quando sono andato in America veramente mi sono reso conto che ero italiano. Da lì ho scelto di esserlo, italiano, sia pure come outsider, con tutta la mia parte americana che mi divideva dagli altri. Anche oggi parlo il “finardese”, un mix di italiano e inglese, perché ci sono ancora tante cose che so dire solo in inglese. Succede così anche a Rossana Casale. Io e Demetrio all’epoca parlavamo inglese. Lo stesso con Camerini. Ma era ed è un italiano misto all’inglese finalizzato alla massima espressione e apertura mentale, il contrario esatto di come adesso si usa sporcare l’italiano con anglicismi che non significano niente, tipo la “macchina performante” o i “prodotti trendy” o, la peggiore di tutte, quando si dice di “avere l’attitudine rock”.
LA SCOPERTA DEL BLUES
Sono cresciuto in una famiglia di musicisti. Ma al Conservatorio di Milano mi hanno bocciato. Era il 1965. Il motivo? Avevo corretto Béla Bartók, i Mikrokosmos, scrivendo a china sul rigo musicale. All’epoca non conoscevo la musica moderna e non ero mai stato esposto alle dissonanze. Avendo studiato musica barocca, ho ingenuamente voluto fare una correzione. Scandalo! Così, pur avendo sempre studiato il pianoforte, poi ho saltato il Conservatorio e non ho mai imparato a leggere la musica, o comunque faccio molta fatica. Proprio quell’estate, però, sono stato in America dalla nonna e ho subito l’uragano del rock. Ho visto i Rolling Stones in televisione che suonavano Satisfaction. In più mio cugino, credendomi fan dei Beatles e pensando di farmi un torto, mi ha regalato i primi tre dischi dei Rolling. Quel regalo ha cambiato la mia vita. Mi si è acceso allora l’amore per il blues e, come molti altri, non solo italiani, ho fatto il percorso a ritroso, dal blues bianco degli Stones su fino alle origini. Poi, quando sono tornato in Italia, ho voluto comperare una chitarra elettrica, una Eko. E da lì sono andato avanti…
GLI INIZI
Ho iniziato a suonare con i musicisti della mia adolescenza, tra cui Alberto Camerini. Facevamo i pezzi di Fire And Water dei Free, quelli di Paul Rodgers e Paul Kossoff. Rodgers cantava in un modo incredibile. Suonavamo con il mio amico Oliver Strimple, sassofonista e flautista, un ragazzo ebreo inglese nato in India, i cui genitori, tedeschi, erano sfuggiti alla persecuzione nazista. Poi è diventato uno scienziato del Mit, uno di quelli che hanno misurato le dimensioni dell’universo con l’effetto Doppler… Poi ovviamente c’erano Fabio Treves e tutti gli altri. Erano gli anni del viaggio al Festival dell’isola di Wight, con Donatella e Lucio Bardi. Era una compagnia di musicisti in cui tutti suonavamo soprattutto il blues. Tutti i soldi che ricevevamo finivano nei dischi, anzi ci mettevamo d’accordo per non comperare doppioni e ascoltarli tutti. Mi ricordo il debutto a 33 giri dei Led Zeppelin. Quel disco lo abbiamo ascoltato per la prima volta tutti insieme a casa di un amico, religiosamente. Lo abbiamo messo sul piatto e poi è successo il finimondo. Quel primo brano, Good Times, Bad Times, ci ha sconvolto. In quegli anni ci sono stati tanti esordi sconvolgenti. All’isola di Wight con Camerini e Treves abbiamo assistito al primo concerto in assoluto degli Emerson, Lake and Palmer. Mi ricordo ancora l’inizio con la presentazione dei loro nomi accompagnati dai colpi di cannone. In mezzo a 400mila persone. Poi, ovviamente, i Free, Hendrix e gli Who, che suonarono tipo alle 4 del mattino. Molti di noi dormivano. Io ero sveglio per fortuna.
GLI ANNI DEI FESTIVAL
La voglia di festival, in Italia, è arrivata nei primi anni ’70. I primi sono stati quelli organizzati dalla rivista «Re Nudo». Io ho suonato solo a quello di Zerbo del 1972, sul Po in provincia di Pavia, perché spesso ero via. Quella volta abbiamo suonato solo noi attaccando una prolunga che ci era arrivata da una contadina. Io suonavo il sitar, andando avanti tutta la notte con la gente intorno. Nel 1973 ci fu l’estate a Terrasini, la prima comune hippie italiana, voluta in Sicilia da Carlo Silvestro, poeta e giornalista romano, dove si incontrarono il ramo psichedelico del Movimento Studentesco, quello di «Re Nudo», con Claudio Rocchi, Camerini, Paola Pitagora, l’artista Guido Daniele, insieme a Mauro Rostagno e gli altri di Lotta Continua. Da lì si presero gli accordi per i festival successivi, di cui i più famosi saranno quelli del parco Lambro di Milano del 1974, ’75 e ’76, i primi due più piccoli ma anche più d’avanguardia. Nel primo suonai con la mia prima formazione, con cui feci il mio esordio con i primi singoli del 1973, Spacey Stacey e Hard Rock Honey, entrambi usciti con la Numero 1. Poi ci suonai ancora nel 1976.
IL PUBBLICO ITALIANO ERA CAMBIATO
Nei festival non c’erano più solo i “freakkettoni” italiani: c’erano studenti, proletari e semplici borghesi, tutti alla ricerca di qualcosa di nuovo. Al parco Lambro si sono visti i primi studenti universitari che arrivavano dal proletariato, dopo l’apertura degli atenei a tutti. Era avvenuto nel giro di pochi anni un cambiamento epocale. Quando io ero nelle scuole dell’obbligo, era impensabile che i figli degli operai andassero all’università. Nelle scuole dell’obbligo i figli degli operai venivano messi nei banchi in fondo, perché il maestro diceva che tanto poi sarebbero andati a lavorare. Poi è arrivato il 1968 e le cose sono cambiate: sono arrivati il pacifismo, l’uguaglianza, la psichedelia, la musica, la controcultura, le droghe. Il ’68 è stata una spinta a cambiare la vita prima che la vita cambiasse noi, ed è partito da tutti i giovani, universitari e proletari. è stato l’immaginazione al potere, con le comuni, i jeans, i capelli lunghi e così via. Venivamo da un mondo alla De Amicis e nel giro di pochi anni è veramente cambiato il modo di pensare.
CREATIVITÀ, IMPEGNO E ROCK
Oggi quella cultura ha vinto, ma allora era tutto nuovo, eravamo un’avanguardia. Negli anni ’70 in una cena della Cramps, la casa discografica di Gianni Sassi, ci trovavo Demetrio Stratos, Paola Pitagora, John Cage, Nanni Balestrini, gli operai dell’Alfa Romeo… Era un calderone di cervelli in movimento, dentro ai quali passavano autentici ciclotroni di idee, che poi davano frutti diversi e incredibili in ogni ambito. John Cage produceva le sue idee, io le mie, ma per tutti c’era l’idea di far parte di un collettivo, di cui faceva parte anche la musica. Una canzone come Musica ribelle ha una forza che nasce dal fatto che non prevale nessuno, c’è una spinta comune, che è l’idea del ’68. Anche se Camerini e io eravamo la parte più psichedelica del movimento. Ed eravamo molto criticati per questo. È successa la stessa cosa dieci anni dopo, negli anni ’80 inoltrati. Mi ricordo che era apparso all’orizzonte Jovanotti e tutti gli davano del sempliciotto. Eppure è quello che è andato più avanti e che è rimasto più attuale. A me dieci anni prima era successo lo stesso. Ero criticato. Mi dicevano che non ero politico e non ero poetico. Ma io volevo essere quello: volevo essere utile. Erano canzoni politiche scritte con l’ottica di un ragazzo di 22 anni. Musica ribelle, Extraterrestre, Non è nel cuore e così via erano tutte canzoni estremamente politiche, anche se il mio modo di scrivere non era figlio del liceo classico ma bensì delle high school americane. Ero molto più rock, all’opposto di un Pietrangeli o di un Guccini, e mal sopportavo un certo tipo di cantautori italiani.
La genesi della Musica ribelle
La genesi di queste canzoni è tutta in quegli anni. Ormai vivevo da solo a Milano, perché i miei erano tornati in America il 30 aprile del 1975, lo stesso giorno della caduta di Saigon e della fine della guerra nel Vietnam. Vivevo con Lucio Fabbri, musicista polistrumentista poi nella PFM e direttore d’orchestra. Un giorno ho preso la chitarra in mano e Musica ribelle è arrivata, parole e musica insieme. All’inizio era un arpeggio, perché io avevo un modo di suonare con le mani, senza plettro, anche se poi nel disco l’ho suonata con il plettro. Era una chitarra acustica suonata come una ritmica, che in sala di incisione si è unita al classico trio di batteria, basso e pianoforte, senza mai fare un assolo. Sovrainciso poi c’è Patrizio Fariselli con i fiati, il sinth e l’Arp 2000, oltre ai mandolini di Lucio Bardi. Perché doveva essere un pezzo italiano. Musica ribelle è nato con l’espresso scopo di fare il rock italiano. Essendo io americano, mi era molto ben chiaro che cosa fosse il rock, contrapposto alla musica italiana, e sapevo suonare come loro, visto che facevo le canzoni dei Jethro Tull, dei Cream. Ma sapevo molto bene che era ridicolo farlo in italiano. Era forzato. Viene fuori quello che facevano i Camaleonti, l’Equipe 84 e i Dik Dik: rispettabilissimi, ma non era rock. Il rock italiano non si suona più in cinque battute come l’inglese, il pentametro, ma segue naturalmente l’endecasillabo, la forma ritmica naturale della nostra complicatissima lingua. In italiano, per esprimere un concetto, devi usare il doppio delle parole dell’inglese. L’inglese è una lingua “balistica”, che spara parole molto accentate come proiettili. L’italiano invece ha un ritmo serrato e continuo, tipo “ta ta ta ta ta”, senza accenti, per cui devi usare un ritmo che segue questo andamento, con il charleston e la chitarra velocissima e in sedicesimi. Il contrario del blues americano. Sono così Musica ribelle ma anche Diesel ed Extraterrestre. Tutti questi pezzi hanno un andamento che si adatta alla lingua italiana. È una scelta che ho fatto quando ho scoperto che mi stavano antipatici gli americani e in generale gli anglosassoni.
LA MUSICA ITALIANA
Gli anglosassoni hanno un atteggiamento di superiorità, da veri colonialisti. Noi no. Quindi con la mia musica ho cercato volutamente di dimostrare che non siamo da meno e che, soprattutto, non ci limitiamo alla musica melodica, anche se abbiamo una nostra identità. Musica ribelle infatti, subito dopo l’avvio, non ha l’entrata in scena di una chitarra elettrica, ma di un violino. Nell’inciso entra il mandolino che passa attraverso un Marshall da 200 watt settato come quello di Hendrix. E fa venire giù i muri. Ecco la musica italiana: sono tutti pezzi costruiti in maggiore (mentre il blues usa la pentatonica minore) e che seguono scale vivaldiane. Franco Fabbri in un libro che ha scritto su di me dice, anche con un accenno di critica, che in fondo io scrivo solo canzonette mozartiane. Ed è la verità. Da figlio di una cantante lirica e da italoamericano, io scrivo arie e suono il blues. Ma con il blues fatto in italiano ci ho provato e non funziona. Anche perché il blues è una espressione gutturale e richiede una lingua che venga dalla pancia. L’italiano, invece, viene dalla testa, a meno che tu non sia napoletano. Ma essendo io milanese non potevo farlo. Ci ho provato poi con il fado a togliermi questo sfizio. Ma questa è un’altra storia. Come quella di Carlo Boccadoro che mi ha fatto cantare Vladimir Vysockij, il cantautore russo. Meraviglioso.