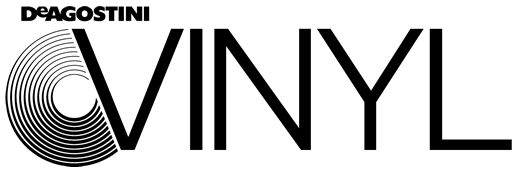All’arrivo degli anni ’80 David Bowie è già un veterano. Il fragile e misterioso Ziggy Stardust si è tramutato in un genio, in un profeta assoluto del trasformismo rock. Generatore e anticipatore di musiche che altri sentiranno solo molto dopo. Eppure qualcosa gli sfugge. Ancora per poco
di John Earls – Stefano Solventi
cover story integrale pubblicata su Vinyl n.7 (marzo 2019)
foto: Les Zg – licenza CC Attribution-Share Alike 4.0 International
[Continua da David Bowie, let’s dance – pt. 1]
Proprio la fine di Ziggy evidenzia un aspetto: è come se Bowie temesse di finire cannibalizzato dalla fama. Gli spostamenti stilistici e geografici successivi lo portano a inseguire il successo e contemporaneamente ad allontanarsene. Prima realizza il plastic soul di Young Americans e il wave-soul-kraut di Station to Station in quel di Los Angeles (impersonando nel frattempo L’uomo che cadde sulla terra nel film di Nicolas Roeg). Poi fa rientro in Europa dove, oltre a salvarsi da una tossicodipendenza rovinosa, ignora a bella posta il punk imperante, definendo con la cosiddetta “trilogia berlinese” le basi di molta new wave ed etno-elettronica degli anni a venire.
Questo vortice sperimentale, occorre ribadire, non è affatto incompatibile con il successo. Semmai mira a ottenerlo in una prospettiva di eccezionalità, di shock emotivo e frattura culturale. Nell’album Scary Monsters (and Super Creeps) del 1980 sembra quindi convergere tutto il percorso compiuto da Bowie fino ad allora. Pur trattandosi di un lavoro sostanzialmente popular, non rinuncia a dettare le regole di un immaginario inquietante e in divenire. è il preludio di una svolta clamorosa: oramai ultratrentenne, lasciate alle spalle le insicurezze e le dipendenze, Bowie sente di essere finalmente padrone del se stesso artista e uomo.
Progetta quindi di dominare quel successo che la congiuntura culturale e tecnologica gli sta spianando davanti agli occhi. E, come sappiamo, ci riesce. Diventa un protagonista assoluto degli Eighties dal punto di vista musicale, cinematografico (con risultati, diciamo così, alterni) e più in generale iconografico. Per molti fan quel consegnarsi al pop rappresenterà un tradimento e in un certo senso lo è stato, ma non tanto per la brama di successo, che Bowie in fondo ha sempre avuto: casomai, tradisce il suo pubblico nella misura in cui rinuncia quasi del tutto a inquietarlo, barattando l’inquietudine con il glamour più patinato. Va aggiunto che si tratta, nel contesto di quegli anni, di applicare la formula perfetta per ottenere una pop-music di alto profilo, destinata a dettare con album da questo punto di vista riuscitissimi – soprattutto Let’s Dance – i principali standard produttivi ed espressivi dell’epoca.
[Continua con la parte tre]