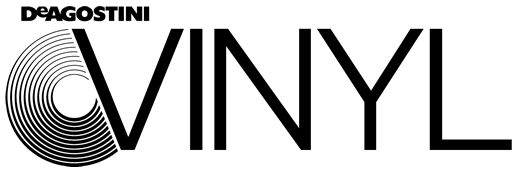All’arrivo degli anni ’80 David Bowie è già un veterano. Il fragile e misterioso Ziggy Stardust si è tramutato in un genio, in un profeta assoluto del trasformismo rock. Generatore e anticipatore di musiche che altri sentiranno solo molto dopo. Eppure qualcosa gli sfugge. Ancora per poco
di John Earls – Stefano Solventi
cover story integrale pubblicata su Vinyl n.7 (marzo 2019)
foto: YouTube
[Continua da David Bowie, let’s dance – pt. 5]
Se molti considerarono Never Let Me Down il punto più basso di David Bowie – più per le sonorità che altro, potendo comunque vantare alcuni pezzi molto buoni, come la title track e Time Will Crawl – Bowie stesso avverte il bisogno di smarcarsi. E lo fa nella maniera più inattesa.
Si “rifugia” dietro a una band, i Tin Machine, con i quali pubblica due dischi non memorabili, ma utili a consumare il salvifico strappo in direzione di un rock più ruvido (dimostrandosi ben sintonizzato con il nascente grunge). E’ infatti la tabula rasa necessaria a reinnescare il processo creativo.
Bowie riparte con il più che discreto Black Tie White Noise del 1993, elettrico ma solcato di umori elettronici, e prosegue due anni più tardi con il tuffo in area industrial e avant (assieme a Brian Eno) di Outside, nel quale introduce un nuovo personaggio, il detective Nathan Adler. E’ ora lecito parlare di seconda giovinezza artistica, se è vero che neppure due anni più tardi, nel gennaio del 1997, esce Earthling, convincente escursione in territori jungle, techno e industrial, che lo vede incrociare l’estro con Trent Reznor dei Nine Inch Nails (I’m Afraid of Americans) e Moby (Dead Man Walking), con il clip della magnifica Little Wonder a inquietare l’immaginario collettivo grazie alla regia visionaria di Floria Sigismondi.
Prima della fine del secolo, c’è tempo per un altro album, ‘hours…’ (1999), che sembra voler ripercorrere i molti stili della sua carriera, mentre il successivo Heathen consegna al terzo millennio un Bowie in grande spolvero, nuovamente prodotto da Tony Visconti e con ospiti quali Dave Grohl, Tony Levin e Pete Townshend. E’ il preludio a Reality del 2003, non ispiratissimo ma destinato a grandi riscontri commerciali, il cui tour è però interrotto bruscamente a causa del blocco di un’arteria coronaria, avvenuto dopo il concerto di Scheeßel, in Germania, del 25 giugno 2004.
Il conseguente ritiro dalle scene coincide con una vera e propria eclisse di Bowie, sostanzialmente sparito dai radar proprio mentre tra i media si impone il codice espressivo pervadente del web. Fa quindi enorme sensazione il suo improvviso ritorno, l’8 gennaio 2013 (giorno del suo sessantaseiesimo compleanno), con The Next Day, album sorretto da un’ispirazione robusta e stilisticamente variegata, il suo lavoro migliore dai tempi di Scary Monsters.
Esattamente tre anni più tardi, altrettanto improvvisa è l’uscita di Blackstar, sconcertante incontro di impro-jazz e rock-soul per sette tracce affascinanti ed enigmatiche, nelle quali si cela una profonda riflessione sulla morte imminente, avvenuta tre giorni più tardi, la notte tra il 10 e l’11 gennaio 2016, per le conseguenze di un tumore epatico.
Forse mai un artista è stato in grado di incanalare la propria morte in un percorso espressivo di tanta sorprendente bellezza, congedandosi dal mondo più vivo e perturbante che mai.
[Vai alla parte 7]